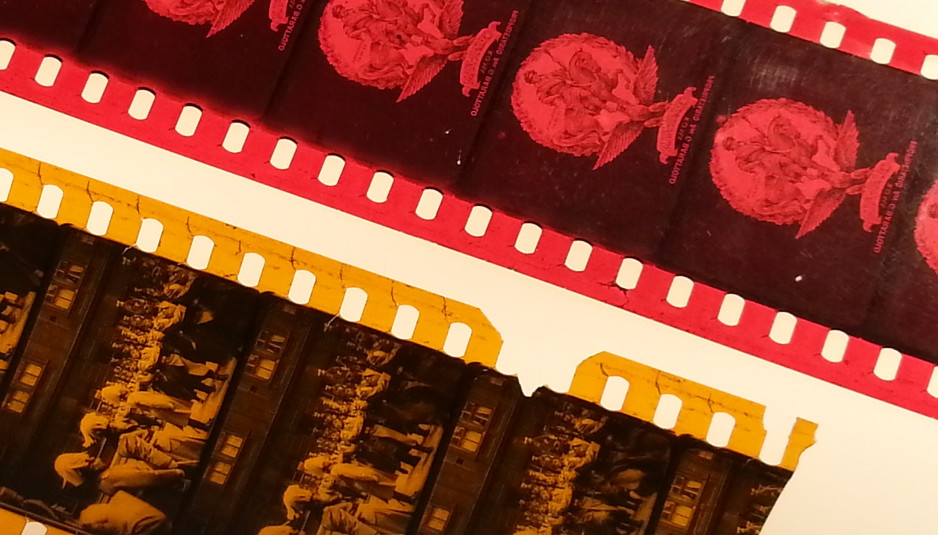Alle soglie del rinnovo della Convenzione tra la Rai e lo Stato Italiano (l’attuale scade nel maggio 2016), moltissime sono le minacce che insidiano la sopravvivenza dei servizi pubblici europei, dalla difficoltà di reperire risorse finanziarie al declino di fiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, dalla moltiplicazione dei canali e delle piattaforme ad una competizione sempre più accesa sui contenuti premium, dalle trasformazioni e disintermediazioni della tradizionale catena del valore al ruolo sempre più centrale dei nuovi gatekeeper (aggregatori, over the top, ecc.), dalla struttura organizzativa elefantiaca e poco efficiente di molti broadcaster pubblici alla migrazione delle utenze più giovani verso nuove forme di consumo[1].
L’effetto è moltiplicato nel nostro Paese, dove la Rai, negli ultimi anni, ha faticato non poco nel rispondere con tempismo ed efficacia ai mutamenti della società. E la ragione principale, di questo vulnus, va ricercata nella debolezza della sua mission, ovvero nella incapacità di definire con chiarezza obblighi ed obiettivi dell’azienda radiotelevisiva pubblica.
Una forte confusione, o meglio densa nebbia, sulla missione pubblica della Rai, si protrae infatti da molto tempo[2]. Il dibattito sulla dipendenza dalla politica, identificata come male principale della Rai nel nostro Paese, è stato purtroppo funzionale ad offuscare il vero dibattito sull’assenza di un chiaro, condiviso, trasparente, efficace progetto pubblico. Così la mancanza di regole e obiettivi certi ha permesso, a tutti i governi che negli anni si sono succeduti, di operare senza trasparenza pensando più al beneficio privato che al bene comune. Invece di trascorrere tanto tempo a discutere del come (la governance, le risorse ecc) avremmo forse dovuto maggiormente riflettere sul cosa (la visione, il progetto).
Rispetto agli auspici di una importante fetta dell’opinione pubblica che la Rai venga privatizzata, è invece chiaro che l’unica giustificazione nel negare questa strada è quella di difendere – e rafforzare – una sua funzione pubblica. In questo senso credo sia utile ripartire proprio da qui. Dalla mission.
Ragionare sulla mission significa principalmente chiedersi che senso abbia oggi, in piena era del digitale, che lo stato finanzi un servizio pubblico radiotelevisivo e se davvero questo importante segmento del mercato dei media[3] vada oggi difeso e preservato, in Italia e nel mondo.
Nella riflessione che segue provo ad argomentare che un senso ancora sussiste, e che nel nome di questo la mission debba poggiare su due colonne portanti: una spinta gentile verso il proprio pubblico e una spinta forte e determinata nei confronti del sistema economico del Paese.
Il valore per il sistema economico
Iniziamo dalla spinta forte e determinata.
La Rai è una delle più importanti istituzioni pubbliche del Paese, la più importante nell’ambito dei settori culturali e creativi, con un fatturato consolidato (2014) di 2,5 miliardi e introiti pubblici (da canone) di 1.590 milioni di euro. Per capirne il valore basta raffrontare questa cifra al bilancio complessivo del Mibact, che per il 2014 è stato di 1.595 milioni di euro, e del Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo, ovvero l’ammontare delle risorse che il Mibact investe in tutte le iniziative culturali del Paese) che, nel 2014 (stessi dati si aspettano per il 2015), è stato pari a circa 406 milioni di euro.
L’attività principale di Rai è quella di realizzare un palinsesto di qualità, le cui caratteristiche specifiche sono definite dalla mission, indicata nella Convenzione con lo Stato[4] e poi elaborata nei diversi Contratti di Servizio che vengono rivisti ogni cinque anni[5].
Se quindi il prodotto del broadcaster pubblico è il palinsesto e la sua identità peculiare è data dalla specificità della sua mission, fin dalla nascita dei servizi pubblici europei è risultato evidente quanto la funzione di indirizzo, governance e distribuzione di un palinsesto pubblico non coincidesse, necessariamente, con il controllo di altre porzioni della filiera, ad esempio quella della produzione. E che anzi compito dell’azienda pubblica potesse essere proprio la formazione di un comparto produttivo, esterno al broadcaster, e quindi indipendente[6].
Non è un caso che gli inglesi abbiano lanciato un canale solo per questo fine, Channel 4, ed era il 1982. Da noi ci ha provato, nel 1998, l’allora viceministro Veltroni a dare un forte impulso al settore, non con un canale ma con una norma, la legge 122[7] che, recependo le ultime direttive europee, prevedeva quote di investimento e programmazione per i broadcaster in cinema e fiction di origine nazionale ed europea. E a seguito della 122, per fare un esempio relativo al solo comparto della fiction[8], gli investimenti Rai in prodotto originale lievitarono dai 93 milioni di euro del 1997 ai 180 del 2001 ai 287 del 2006, con notevoli effetti di indotto su tutto il settore creativo in Italia [9], a dimostrazione di quanto le politiche pubbliche possano fare, in modo evidente ed anche in tempi relativamente brevi, la differenza. Per arrivare ad oggi in cui gli investimenti complessivi dei broadcaster generalisti nel prodotto audiovisivo sono di circa 314 milioni di euro (anno 2015: Rai 194/Mediaset 120)[10].
Si tratta di risultati importanti, ma non sufficienti a portare a maturità la nostra industria nazionale dell’audiovisivo. La scarsità delle risorse economiche, inoltre, si somma ad una gestione dei diritti, da parte dei broadcaster, fortemente autoritaria ed aggressiva, anche grazie al ristretto mercato nazionale della domanda. Ai produttori è quindi negata la titolarità della maggior parte dei diritti, quindi la possibilità di trasformare una library adeguata in asset spendibili sul mercato internazionale. Il risultato è che le imprese italiane non riescono a crescere e ad essere competitive, il prodotto italiano non decolla all’estero (con gravi effetti economici ma anche di reputazione), e la nostra industria dell’immaginario stenta a presentarsi preparata di fronte alle nuove sfide imposte dal digitale e da un sistema in cui la “buona narrazione” diviene lo strumento principe per la costruzione delle audience e dei cittadini di domani.
La mancanza di un’industria dell’immaginario solida è infatti un grosso danno non solo per gli addetti del comparto: ha forti ripercussioni anche su tutta la filiera dell’immaginario e, soprattutto, sulla valorizzazione dei nostri asset culturali materiali e immateriali. Il patrimonio culturale nazionale perde in questo modo un’ennesima chance: non solo stenta a sopravvivere a fronte dei pochi strumenti di tutela, e a farsi driver di crescita – a fronte di progetti di valorizzazione che solo oggi iniziano a rientrare in una strategia pubblica – ma non gode neanche di sufficienti veicoli di racconto e promozione, in patria e all’estero. E quel poco – pochissimo – di cultura italiana che si vede in video è prodotta dal mercato anglosassone, dalle serie americane su Roma ai documentari britannici su Pompei.
Questo rende ben evidente quanto le scelte strategiche dell’azienda impattino sul sistema culturale italiano e sull’economia tutta. Non si tratta quindi – solo – di produrre alfabetizzazione e inclusione sociale, come vedremo più avanti, ma – anche – di attivare una fondamentale filiera economica che, a sua volta, produce effetti di enorme portata su tutta la società.
Per questo il tema della promozione dell’audiovisivo nazionale è centrale. E molti, in particolare tra gli operatori della filiera audiovisiva, lo identificano come il perno della mission Rai. Ad esempio Follini e Tozzi, rispettivamente Presidenti dell’Associazione Produttori Televisivi e dell’Anica, hanno invocato il “pluralismo imprenditoriale” come evoluzione del “pluralismo politico” pensando ad una mission Rai declinata “in funzione dell’industria e dei suoi contenuti”[11].
Il rafforzamento dell’industria audiovisiva è un imperativo categorico che dovrebbe riguardare tutto il settore del broadcasting, magari con quote più consistenti per quello pubblico. Oggi è già così[12], ma la spinta non è sufficientemente forte e determinata. Si auspica quindi da più parti, con il rinnovo della convenzione, una Rai più devota a generare impatti significativi sull’industria, vuoi aumentando le quote di investimento, vuoi con una gestione diversa della filiera dei diritti. Il come andrà definito dalla nuova dirigenza dell’azienda pubblica.
Si tratta di un come che, però, non può prendere in esame solo la componente quantitativa. Agire nel nome del bene comune significa, infatti, anche e soprattutto finanziare innovazione di prodotto e di sistema[13]. Quindi la specificità della Rai impone che si guardi con maggiore attenzione a quei produttori o a quei programmi maggiormente innovativi che non troverebbero naturale sbocco nel mercato, o che avrebbero difficoltà a fronte di elevati rischi, riservando loro porzioni di programmazione e investimento. Va ricordato che il lavoro di costruzione di nuove audience (e di una industria nazionale più innovativa!) è lungo e impervio, e quindi il processo di sperimentazione di nuovi linguaggi non può non passare attraverso un percorso irto di ostacoli[14]. Una “pazienza” questa che si addice a chi ha compiti istituzionali, non al mercato.
Se è quindi centrale, nel mandato Rai dei prossimi anni, una influenza più rilevante nel settore dell’audiovisivo, va altresì ricordato che questa influenza deve produrre effetti positivi, sia sul fronte della quantità che su quello della qualità del prodotto. Quindi è giusto stimolare il settore della produzione, ma ancora più giusto, per il servizio pubblico, stimolare il settore della produzione a realizzare prodotti innovativi e di qualità, e farlo con metodi trasparenti ed equi. In particolare sarebbe ora che il sistema degli appalti Rai fosse maggiormente inclusivo e premiante il merito, con trasparenza e secondo codici di condotta chiari e valutabili.
Il tema dell’innovazione, inoltre, non riguarda solo il prodotto ma tutta la sua filiera – dall’ideazione alla produzione, al supporto tecnologico, alla distribuzione, all’archiviazione, ecc.[15] – ed in tutte le sue espressioni è centrale perché indica la strada del rischio che la Rai si sobbarca anche per il resto del comparto, pareggiando così i conti con i broadcaster commerciali.
In questo modo – potremmo dire con Mazzuccato (2014) – il settore agisce da detonatore e stimolo di iniziativa privata, stimolando gli animal spirits del mercato (produttori, imprese tecnologiche, nuove start up…) piuttosto che fare crowding out, ovvero occupare porzioni di mercato potenzialmente destinate al privato, facendo concorrenza sleale.
Certo, la disponibilità finanziaria della Rai è un limite e rende complessi gli investimenti di rischio. Ma il Governo è obbligato, laddove la Rai venga nuovamente investita dal ruolo di faro pubblico per il sistema audiovisivo, a supportarla con strumenti adeguati a conseguire il suo mandato. Peraltro, come suggeriscono le associazioni di categoria dei produttori e degli autori, se le quote fossero oggi rispettate appieno da tutti i broadcaster, il totale di risorse immesso nel comparto della creatività sarebbe molto più elevato, e almeno da qui si potrebbe ripartire.
Il valore per il pubblico
Il rafforzamento del mercato della creatività, specie nella sua componente più innovativa è, però, condizione necessaria ma non sufficiente. A fronte di una molteplice offerta di canali, per quale motivo l’attore pubblico dovrebbe supportarne uno in particolare (o più d’uno, un grappolo di canali), finanziato con i soldi dei contribuenti, e potenzialmente competitivo con la televisione commerciale (e quindi sottraente risorse – pubblicitarie – al mercato)? Se si trattasse solo di spingere l’audiovisivo non basterebbe mettere delle quote più stringenti per i canali commerciali e dar loro i finanziamenti pubblici per ottemperare agli obblighi di programmazione, magari con un occhio alla qualità?
E’ inoltre sempre valida l’annosa domanda: se un amplissimo numero di opzioni (canali televisivi) dà automaticamente agli utenti una grande libertà di selezionare il meglio (pluralismo esterno), a cosa serve un broadcaster pubblico? Qual è, per usare un termine inglese che è diventato il mantra di tutti i dibattiti europei sul tema, la sua “legitimacy”? Inoltre perché io cittadino che voglio guardare solo i canali commerciali dovrei pagare per qualcosa di cui non usufruisco? Se si tratta solo di un’integrazione, quindi massimizzare ancora di più la scelta, hanno ragione coloro che promuovono una pronta privatizzazione della Rai.
Il ruolo del pubblico si giustifica, infatti, solo ed esclusivamente qualora offra un servizio unico (quindi di chiara identità specifica) e che produca bene pubblico. In questo caso anche chi non ne usufruisce può comunque trarre un vantaggio sociale dall’esistenza di quel bene, perché ha potenziali ripercussioni sullo sviluppo e l’inclusione sociale e, quindi, aumenta il benessere collettivo.
Il servizio pubblico ha, quindi – questo è il punto! – un mandato, unico, cioè quello di identificare e programmare un palinsesto (svariati palinsesti) che aiuti a migliorare le competenze e quindi le condizioni di vita delle persone[16].
Per fare questo vengono prodotti o selezionati strumenti diretti (informazioni) e indiretti (valori e macro-concetti) che facilitano la comprensione dei cambiamenti sociali, del mondo che ci circonda, dell’enorme gamma delle possibilità di scelta che si aprono davanti all’essere umano, insomma strumenti di libertà.
Chi seleziona i programmi e compone il palinsesto del servizio pubblico è dunque un “architetto delle scelte” come chi dispone gli alimenti in una mensa scolastica (Thaler&Sunstein, 2008), solo che la mensa, in questo caso, è una tra le centinaia a disposizione di un utente con il telecomando in mano e questo cambia radicalmente le strategie da mettere in gioco.
Mantenendo la metafora di Thaler&Sunstein non ci si può, quindi, limitare a mettere in primo piano gli ortaggi se poi sul canale concorrente brillano a tutto schermo le patatine con ketchup. Oltre agli strumenti dedicati (diretti e indiretti) il servizio pubblico dovrà essere, allora, anche moderatamente attrattivo, altrimenti non potrebbe realizzare il suo mandato[17]. Ma essere attrattivo non è parte del suo mandato, è uno strumento. La missione è una spinta gentile all’inclusione sociale, al miglioramento della società.
Non si tratta neanche, però, di ospitare all’interno dello stesso gruppo di canali sia le patatine con il ketchup che le carote bio, lasciando poi agli ascoltatori la scelta di cosa consumare (pluralismo interno). Se non c’è progetto editoriale, se non c’è una responsabilità del servizio pubblico nel gestire, assieme, la complessità delle scelte ed aiutare gli utenti a comprenderne la portata e gli effetti, allora proprio non si capisce cosa rappresenti l’unicum della Rai rispetto ai competitor commerciali.
Per questo credo sia molto efficace la definizione coniata dall’EBU di “Return on society”-ROS[18], cioè ritorno sulla società, ad indicare gli effetti benefici del servizio pubblico sui pubblici che compongono il Paese.
Si tratta del superamento del ruolo “educational” con cui sono nati i servizi pubblici in Europa, che prevedeva un’azione unidirezionale. Ora si ragiona sul dialogo, sull’interazione, su cosa fa l’individuo con le cose che incontra, ed è questa interazione che la tv pubblica deve promuovere e “governare”. Può far paura a qualcuno l’idea di una Rai “paternalistica” o che governi le nostre interazioni, o almeno ci provi con una spintina. Ma altrimenti a chi e cosa dovrebbe giovare un servizio pubblico? Se non a fare delle scelte, la composizione di un palinsesto, che il privato non farebbe?
Proviamo a fare un esempio concreto per comprendere meglio di cosa parliamo. Facciamo il caso di una tornata elettorale. Un’alta percentuale di elettori è simbolo di democrazia, di un ampio coinvolgimento dei cittadini alle scelte sulla cosa pubblica e quindi, tra i compiti del servizio pubblico, ci può essere anche quello di spingere i cittadini ad andare a votare. Per fare questo verranno adottate delle strategie. La più ovvia (anche senza aver letto i suggerimenti di Thaler e Sunstein sugli effetti emulativi, p. 63) è quella di lavorare sul concetto che votare ha un valore positivo. Allora, per ipotesi, mentre i canali commerciali evidenzieranno i rischi del non-voto, mettendo in evidenza gli elementi critici (quanti non hanno votato nelle tornate precedenti, quanti probabilmente non voteranno a questa, i rischi per la democrazia ecc), e questo perché l’informazione “di emergenza” è per sua natura più attrattiva (“vende di più”), i canali pubblici evidenzieranno le buone pratiche e gli effetti virtuosi della partecipazione al voto.
Questo esempio è utile perché mostra quanto ci si stia muovendo in un campo minato. Pensare al servizio pubblico che lancia un messaggio, che usa l’informazione per spingere certi comportamenti, può fare paura. Appare demagogico. Finanche autoritario. Ma il mito opposto, quello di un’informazione neutrale, totalmente obiettiva, è smentito dalla storia e dagli studi di sociologia. Non esiste informazione completamente neutrale così come non esiste un Governo completamente assente[19]. E senza arrivare al caso di un telegiornale che sposa la linea di un determinato partito politico e condiziona le informazioni veicolate a questo fine, basta pensare, appunto, al fatto che per raggiungere più audience la maggioranza delle testate giornalistiche (stampa, tv, internet o radio che siano) drammatizza gli eventi incrementando di conseguenza gli stati ansiosi della popolazione e anche l’impotenza verso il cambiamento (se tutto va male e non ci sono vie di uscita è inutile che io cerchi di fare qualcosa di positivo…).
Adattando le parole di Thaler e Sunstein (p.82) – “[…]nonostante tutte le loro virtù, spesso i mercati danno alle aziende un incentivo ad assecondare le debolezze umane (per trarne un profitto), anziché cercare di sradicarle o di minimizzarne gli effetti” – potremmo attribuire ai gruppi media commerciali questa naturale propensione, cioè trarre profitto dalle debolezze umane, laddove invece il servizio pubblico è chiamato a cercare di sradicarle o, almeno, minimizzare gli effetti.
Naturalmente la tv commerciale è anche ben altro. Le tv commerciali, in Europa come nel mondo, hanno avuto senz’altro un ruolo di spinta, di “modernizzazione”, molto rilevante. Ma senza un mandato pubblico specifico, senza un perimetro di azione. Senza delle garanzie di pubblico servizio.
Facciamo un secondo esempio, partendo da un interessante intervento di Aldo Grasso[20]. L’opinionista cita un saggio di Jerome Bourdon[21] nel quale l’autore, proprio per sottolineare la sconfitta del modello di tv pubblica, fa riferimento al suo mancato apporto nella costruzione di una “cultura europea”. Ecco, questo illustra bene il nostro riferimento al bene comune: solo un broadcaster pubblico può intervenire offrendo ai propri utenti una “spinta gentile” verso una idea di mercato e cultura comune europea[22]. Non è stato così fino ad oggi, certo, perché molto poco si sono parlati in questi anni i diversi broadcaster pubblici, ognuno diverso ed ognuno fortemente radicato nelle proprie pesanti caratterizzazioni locali. Ma questo non significa che non si possa ripartire proprio da qui. E magari pensare al nostro Paese che si fa latore di un progetto europeo che coinvolga tutti i servizi pubblici, per programmare assieme, per progettare assieme, una idea di Europa. Questo i broadcaster privati non hanno nessun incentivo a farlo. I pubblici sì, perché la tv pubblica ha come mandato di creare cittadini migliori, “di offrire a chi lo voglia di essere cittadino più consapevole […], persona più libera e più padrona delle proprie scelte”[23].
Il termine “gentile”, quindi, restituisce molto bene quella delicatezza con la quale ci si deve rivolgere al proprio pubblico. Questo non vuol dire, però, che la voce con cui l’istituzione parla non debba essere forte e chiara, perché anzi è necessario che questa si levi nuovamente autorevole ad indicare una direzione che segni una forte assunzione di responsabilità. E’ necessario quindi che talvolta quella gentilezza divenga rude e finanche disturbante, perché deve avere un suo segno e una sua riconoscibilità. Pensiamo ad una tv pubblica che funga, anche, da “pietra d’inciampo” – una tv d’inciampo! – per il Paese. Che ogni giorno getti nell’agenda pubblica temi, aggettivi, riflessioni nuove, stimolanti, che producano impatti ed effetti chiari nel dibattito e generino code lunghe di pensieri ed azioni dedicate al bene comune.
Questo vuol dire, anche, che il gioco deve sempre avvenire all’interno di un accordo di fiducia e condivisione con lo spettatore. Anzi, all’interno di un progetto in cui il ritorno bidirezionale è in grado di produrre correttivi e cambiamento.
Il tema non è quello di una Rai multipiattaforma, perché questa è una dimensione obbligata che riguarda ormai tutti i servizi (non solo radiotelevisivi), pubblici o privati che siano. Non è un caso che ormai non si parla più di broadcasting ma di “public service media”.
E non è nemmeno quella dell’”engagement”, cioè del coinvolgimento del pubblico a partire da un programma televisivo (una notizia, una canzone ecc), della costruzione di relazioni mediante ed intorno all’informazione/narrazione, strumento strategico per fidelizzare lo spettatore ma soprattutto inserire l’utente in una filiera di partecipazione e consumo di prodotti correlati (al programma).
No, la vera novità oggi, è quella della partecipazione e condivisione. Cioè di un progetto pubblico (di valori e servizi), non più unidirezionale, ma mediato e arricchito da una continua immissione/scambio di nuove idee e suggestioni. Se è giusto, come sopra teorizzato, che la Rai produca idee e valori “pubblici” mediante i quali costruire capitale sociale, è indispensabile, al contempo, che queste idee e valori siano negoziati, continuamente, con tutto il Paese. E questo può e deve avvenire aprendo la Rai ad un dialogo trasparente con tutti gli spazi di produzione di pensiero, quindi scuole, università, centri di ricerca, terzo settore, cittadinanza attiva[24].
Istruzione e formazione del capitale umano, di reithiana memoria, vanno declinati in un principio funzionale alle trasformazioni della società nel XXI secolo, in cui il dialogo e lo scambio tra cittadino e istituzioni è aperto e dinamico, non più unidirezionale.
Il grande errore degli ultimi anni è stato quello di confondere il concetto di “governance partecipata” con la costruzione di nuovi organismi decisionali o consultivi aperti a diverse rappresentanze sociali, con il rischio di ingabbiare nuovamente le forze costruttive e creative dei territori in “postifici” utili al più a fare lobby per un soggetto piuttosto che un altro. La partecipazione, per il servizio pubblico radiotelevisivo (e non solo) ha ben più alto scopo, cioè quello di cooperare, l’istituzione assieme a tutta la società civile “attiva”, per il bene comune. A questo fine provo ad immaginare – ma è proposta da lanciare alla discussione che, mi auguro si avvierà nei prossimi mesi[25] – un organismo interno Rai, per esempio una versione rinnovata dello storico centro studi “Verifica qualitativa programmi trasmessi”[26] che divenga locus di dibattito e confronto continuo con tutti i luoghi di produzione di pensiero e che riporti, le idee e spunti migliori, al CDA, alla Presidenza e alla direzione generale, così da contaminare, mettere in discussione, arricchire, il dibattito interno Rai sulla mission (e il suo aggiornamento periodico contenuto nel contratto di servizio) e sul piano strategico e industriale.
Un ponte continuo con l’“esterno”, con il terzo settore, con le scuole, le università, con grandi e piccoli luoghi di formazione del pensiero permetterebbe, inoltre, di ricostruire un legame profondo con il “locale”, cioè con l’Italia dei mille comuni e delle mille comunità, che Rai regionale fatica da sempre a rappresentare e di cui le emittenti locali raccontano una versione parziale, comunque non pubblica [27].
Insomma la Rai non perde “auctoritas” ma trattiene il rischio “autoritario” mettendo in discussione i propri valori fondanti e così diviene parte di una rete di scambio e produzione di idee. Il risultato finale, così come in tutti i processi di formazione, è che una nuova cittadinanza formata anche dalla spinta gentile del servizio pubblico acquisisca strumenti tali da poter mettere in discussione la stessa Rai.
E condizione irrinunciabile di questo ragionamento è la formazione del nuovo cittadino digitale. Si tratta di uno degli obiettivi della mission Rai non più procrastinabili. Su questo importanti passi avanti sono stati fatti negli ultimi anni, ma ancora la strada è lunga, in un Paese affetto da un importante digital divide, e non solo tra le fasce più anziane della popolazione[28]. Inoltre, è bene ricordarlo, non si tratta solo di fornire a tutti gli strumenti e le tecniche di accesso alla rete ma, anche e soprattutto, di trainare gli utenti verso un consumo multipiattaforma e verso una interazione attiva e produttiva con tutte le piattaforme, promuovendo quindi non solo l’accesso ma anche l’interazione e la produzione di nuovi contenuti (il cd cittadino “prosumer”, crasi di produttore e consumatore).
In linea con questo principio molti sono gli stimoli che provengono dal dibattito europeo, in particolare mi limito a citare l’idea di un servizio pubblico 2.0[29] , di un “public service navigator”[30], e infine di una piattaforma digitale europea dei servizi pubblici[31].
La creazione di un nuovo ecosistema e di una nuova cittadinanza digitale è esattamente quel caso di creazione di un nuovo mercato che identifica Mazzucato nel ruolo dello Stato innovatore che fa da catalizzatore e dinamizzatore di nuovi investimenti da parte delle imprese (“creando la visione, la missione e il piano”[32]).
Abbiamo quindi individuato alcuni valori fondanti della mission pubblica: literacy, cittadinanza digitale, maggiore partecipazione alla cosa pubblica, cura dei beni comuni[33], cultura europea ecc. Sicuramente ce ne sono altri. Allo stesso modo vanno individuati con attenzione gli strumenti per comunicare al meglio con le proprie audience: per esempio mostrando ai cittadini possibili strade per migliorare il proprio futuro, dando maggiore enfasi ai progetti sul territorio che producono effetti positivi ecc. Su questo la nuova governance Rai dovrà confrontarsi nei prossimi mesi, ed è già tardi, perché il fatidico rinnovo della convenzione è uno scoglio inevitabile.
Conclusione
“La cosa importante per il governo non è fare ciò che gli individui fanno già, e farlo un po’ meglio o un po’ peggio, ma fare ciò che presentemente non si fa del tutto”. Queste le parole di Keynes[34] che andrebbero messe ad epigrafe della prossima convenzione Rai-Stato.
Quindi una tv pubblica che occupa un perimetro ben delineato, trasparente, unico e distintivo rispetto a quello della tv commerciale. Una tv pubblica che non è “fuori” dal mercato ma neanche pienamente dentro, occupando spazi distinti e complementari ma interconnessi. Se infatti le risorse pubblicitarie che affluiscono in Rai sottraggono potenziali introiti alla televisione commerciale, il ritorno per quest’ultima potrebbe venire proprio dal rischio che la tv pubblica si assume, mediante la sua mission, di investire in innovazione[35], promuovendo nuove idee e nuovi mercati e, quindi, restituendo a tutto il comparto media credibilità del prodotto italiano, sviluppo di creatività, e formazione del pubblico.
“Nessun paese è mai cresciuto senza massicci investimenti in aree fondamentali come l’istruzione, la ricerca e la formazione del capitale umano” (Mazzucato, pag. XIII). Ragionare sulla mission ci aiuta a ricordare perché i soldi pubblici spesi per la Rai sono un buon investimento. E l’ investimento nella “nuova Rai” darà, nel medio e lungo termine, dei ritorni importanti per il Paese, assolutamente misurabili in termini di capitale sociale e sviluppo economico. Anzi, il tema della misurabilità di questo valore pubblico è di indubbio interesse e un buon materiale di studio per gli economisti, laddove tra le prossime sfide che la nuova governance Rai si troverà di fronte, quella degli indicatori in grado di rendicontare il valore dell’investimento che il governo pone sul servizio pubblico è sicuramente strategica e necessaria. Non a caso la questione è in cima all’agenda dei principali servizi pubblici europei e dell’European Broadcasting Union.
Questo significa avviare strumenti di verifica e valutazione periodici sugli obiettivi raggiunti, su quanto effettivamente il servizio pubblico stia producendo valore, e, quindi, sulle performance del management dell’azienda. Temi caldi ma non per questo evitabili.
Nessuno dei temi sopra sollevati è più a lungo evitabile. Il momento per una discussione seria sul senso della Rai è ora. E maggio è alle porte.
Il dibattito è aperto.
Bibliografia essenziale
100autori, AGPCI, ANAC, ANICA, APT, ART, DOC/IT, PMI Cinema e Audiovisivo , Cambia canali, Perché un nuovo servizio pubblico http://www.anica.it/news/cambia-canali
Articolo 21 – Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Gruppo di lavoro per il rinnovo della Convenzione Stato – Rai (2013), Una nuova carta d’identità per la Rai, 9 maggio
Barca F. e Marzulli A. (2007) L’industria della produzione di fiction, per Apt, Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio. http://www.fondazionerosselli.it/DocumentFolder/Presentazione%20IEM%20al%20Roma%20Fiction%20Fest%2005-07-2007%20DEF.pdf
Barca F., a cura di (2007) Le Tv invisibili. Storia ed economia del settore televisivo locale in Italia, Rai-Eri
Brevini B. (2015) The struggle for PSB 2.0: An assessment in International Journal of Digital Television, volume 6, number 2, Intellect Ltd Editorial
Burri, M. (2015), Public service media, contemplating a “Public Service Navigator”: In search of new- (and better-) functioning public service media, International Journal of Communication, n 9, p. 1341–1359.
DCMS (2015), BBC Charter Review, Public Consultation, October 2015 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445704/BBC_Charter_Review_Consultation_WEB.pdf
De Blasio E., Sorice M., a cura di (2014) Il servizio pubblico. Pluralismo, democrazia, media, Focus in Media, Fondazione per la Sussidiarietà, Milano
Ebu Knowledge Exchange 2014, Reaching Young Audiences: The Fragmented Media Landscape as an Opportunity for Public Service Media. – http://www3.ebu.ch/calendar/KX14
EBU (2014) Vision2020 – http://www3.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/EBU-Vision2020-Full_report_EN.pdf
Follini M. e Tozzi R. (2014) Il momento per la riforma della Rai è adesso, Il Sole XXIV Ore, 12/11/2014 http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-11-12/il-momento-la-riforma-rai-e-adesso-064104.shtml?uuid=ABFihwCC
Gandy O.H. (2015) Toward a Political Economy of Framing: Putting Inequality on the Public Policy Agenda,The Political Economy of Communication, 3(2), www.polecom.org
Giacomelli A. (2015) Cultura e innovazione, ecco il servizio pubblico, in Corriere della Sera 4 luglio 2015, file:///C:/Users/Roma/Downloads/Giacomelli%20Corsera%204lug15.pdf
Grasso A. (2015) Tv e servizio pubblico, le buone intenzioni non possono bastare, in Corriere della Sera 29 giugno 2015, http://www.corriere.it/opinioni/15_giugno_29/servizio-pubblico-non-mai-esistito-119a2644-1e30-11e5-958d-f9395af606a3.shtml
Iem (2011) Lo stato di salute della fiction italiana e le dinamiche a livello europeo, III Rapporto Fiction
Infocivica (2014) Per una responsabilità pubblica nelle comunicazioni dell’era digitale, novembre
Klontzas M. (2015) Public service objectives: Contestability and renegotiation in International Journal of Digital Television, volume 6, number 2, Intellect Ltd Editorial
Lilley A. (2013), Counting what counts, febbraio http://www.nesta.org.uk/publications/counting-what-counts-what-big-data-can-do-cultural-sector
Mazzucato M. (2014) Lo stato innovatore, Editori Laterza
Mazzucato M. (2015) The Future of the BBC: the BBC as Market Shaper and Creator, LSE Media Policy Project Blog http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2015/10/14/the-future-of-the-bbc-the-bbc-as-market-shaper-and-creator/
Orf (2014) Public value report 2013-2014 http://zukunft.orf.at/rte/upload/texte/2014/14r0002.pdf
Pallacorda (2015), Linee guida per una riforma della Rai. Mission, governance e finanziamento per un nuovo servizio pubblico, www.pallacordarai.it
Rai (2015) Relazioni e bilanci al 31 dicembre 2014 http://www.rai.it/dl/docs/1433333005555Bilancio_31_12_2014_ver2.pdf
Sen, A.K. (2011) La libertà individuale come impegno sociale, Roma-Bari, Laterza
Tambini D. (2015) Five Theses on Public Media and Digitization: From a 56-Country Study, International Journal of Communication 9, p. 1400–1424
Thaler R.H. e Sunstein C.R. (2009) La spinta gentile, Feltrinelli
[1] Per un approfondimento delle minacce e delle sfide che si trovano oggi ad affrontare i servizi pubblici europei vedi Ebu 2014, Tambini 2015 e Klontzas 2015. Si segnala inoltre l’ampio dibattito che ha seguito la pubblicazione del libro verde edito dal Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport britannico (DCSM 2015) in vista del rinnovo della Royal Charter della BBC: al documento e ai numerosi materiali correlati (tra gli, Mazzuccato 2015) questo articolo non fa, volutamente, alcun riferimento poiché da molti anni – e molti consigli d’amministrazione – una delle scuse per non affrontare con serietà il nodo della mission è stata quella della unicità dell’identità Rai rispetto al classico modello britannico. Nei dibattiti pubblici, e nei documenti privati, la “buona pratica” britannica è sempre stata vista con scherno, e come scusa per bollare l’intero ragionamento come “non applicabile” al nostro Paese. Di fatto, da molti anni, dietro il molto rumore politico la convinzione diffusa è che la Rai sia immodificabile e immutabile, e che spesso il cambiamento (della governance) serva solo a dissimulare la mancanza di cambiamento (della mission). L’autrice di questo articolo, invece, ritiene che si tratti solo di volontà politica, una volontà che nei decenni ha piuttosto rifuggito in Rai qualunque riforma radicale e protetto il mantenimento dello status quo.
[2] “Incalzata dalla concorrenza della Tv commerciale e mortificata nella sua autonomia dall’incontenibile intrusione dei partiti, la televisione pubblica ha progressivamente snaturato la sua missione fino a smarrire, negli ultimi dieci anni, la sua stessa ragion d’essere” (Art.21, pag. 1).
[3] La presenza dei gruppi media pubblici a livello internazionale è imponente e, con le nuove opportunità del digitale, ramifica le proprie offerte: secondo dati Ebu (2014) nel 2013 sono in attività 275 canali televisivi nazionali e internazionali, oltre 180 radiofonici, centinaia i servizi regionali e locali, e oltre 400 i servizi on demand.
[4] La precedente convenzione è stata stipulata nel 1994 http://www.camera.it/_bicamerali/rai/norme/convenz.htm e scade nel maggio 2016.
[5] Secondo quanto previsto dalla legge di riforma passata al Senato il 22 Dicembre 2015. Fino ad allora il contratto di servizio veniva rinnovato ogni tre anni. In realtà, ad oggi, il contratto di servizio non è mai stato un vero luogo di dibattito ed indirizzo della mission, non contenendo neanche sufficienti strumenti per il suo monitoraggio e quindi valutazione ed eventuali correttivi. Non è un caso che l’ultimo contratto approvato è relativo al 2010-2012, e il successivo è in discussione da oltre 3 anni, in una estenuante trafila burocratica e gioco di responsabilità tra Viale Mazzini, il Ministero dello Sviluppo e Agcom, l’autorità di Vigilanza del settore.
[6] Ma la definizione di “indipendente” fa riferimento a quei soggetti che non solo sono esterni al broadcaster ma che, inoltre, non dipendono economicamente da questo, ovvero hanno una quota rilevante di introiti “altri”. Secondo il Decreto 177 del 31 Luglio 2005, “”produttori indipendenti” sono “gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica”. Manca, nella normativa italiana di recepimento della legislazione europea, il rapporto tra indipendenza e titolarità di una library di diritti.
[7]La legge 122 prevede che “I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento” Legge 30 Aprile 1998, n.122, articolo 2. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;122 Al momento il tema è regolato dal Decreto Legislativo 31 Luglio 2005, n.177 (Testo Unico dei Servizi Media e Audiovisivi – TUSMAR), in particolare all’art.44 sugli obblighi di investimento e programmazione per i fornitori di servizi media audiovisivi. Vedi inoltre la Delibera Agcom 30/11/CSP del 3 febbraio 2011.
[8] I dati sugli investimenti del broadcaster pubblico in prodotto cinematografico originale non sono facilmente identificabili. Nel bilancio 2014 Rai Cinema, comunque, dichiara: “Per quanto riguarda la composizione per tipologia di prodotto, gli investimenti effettuati da Rai Cinema in acquisto di film, fiction e cartoni sono pari a milioni di Euro 182,3, gli investimenti in produzione cinematografica ammontano a milioni di Euro 60,6 e gli investimenti in documentari ammontano a milioni di Euro 2,0”. http://www.rai.it/dl/docs/1450431355295BILANCIO_2014.pdf
[9] Barca F. e Marzulli A., 2007 http://www.fondazionerosselli.it/DocumentFolder/Presentazione%20IEM%20al%20Roma%20Fiction%20Fest%2005-07-2007%20DEF.pdf .
[10] Nel corso degli ultimi anni gli investimenti Rai e Mediaset in fiction originale sono stati: 536 mln nel 2008, 360 mln nel 2009, 390 mln nel 2010, 347 mln nel 2011, 285 mln nel 2012, 290 mln nel 2013 (di gran lunga inferiori rispetto agli standard europei: i broadcaster francesi nello stesso anno hanno investito 464 milioni di euro, quelli inglesi 669 milioni), 322 mln nel 2014. In termini percentuali, rispetto al 2008, si stima quindi un calo degli investimenti pari al 60% (dati Apt).
[11] Follini e Tozzi, 2014. Dietro di loro tutta l’industria una volta tanto compatta: vedi 100autori, AGPCI, ANAC, ANICA, APT, ART, DOC/IT, PMI Cinema e Audiovisivo, 2015. Per la posizione dei 100autori vedi in particolare http://www.km-studio.net/clienti/100autori.it/usr_files/100autori_dice/pdf_198966.pdf
[12] Il 15% dei ricavi netti della Rai (canone e pubblicità) – e il 10% per gli editori privati (pubblicità e abbonamenti) – devono essere investiti in opere audiovisive europee di produttori indipendenti (Tusmar). Di queste quote il 20% deve essere investito in opere audiovisive di produzione nazionale.
[13] “Serve una Rai che faccia innovazione, cioè sperimenti nuovi linguaggi, nuovi formati e nuove applicazioni” (Giacomelli, 2015)
[14] Diciamo che, tanto per fare un esempio, se su 10 fiction prodotte da Rai, due fossero ad alta innovazione ed una delle due ottenesse discreti risultati, questo sarebbe senz’altro un risultato più che accettabile.
[15] Vedi anche http://ebu-vision2020.tumblr.com/.
[16] Sen, 2011.
[17] L’attrattività è funzionale anche alla ricomposizione della frattura sociale e generazionale. Importante l’osservazione del gruppo della Pallacorda, 2015: “La televisione sta smettendo di essere fattore di coesione sociale, che raduna intorno agli stessi racconti diverse fasce culturali e generazionali. Questa frantumazione verso target differenziati è fisiologica per la televisione privata free o pay, costa meno, piace agli inserzionisti e rispecchia le tendenze sociali; ma è patologica per il Servizio Pubblico, che esiste in quanto strumento di coesione sociale, volto al rafforzamento dell’identità nazionale e alla valorizzazione delle differenze”.
[18] EBU, 2014: “The term Return on Society relates to the various positive effects that PSM deliver to a specific society, group and individual: the idea that PSM is much more than a bunch of broadcasters delivering content to a wide audience measured in terms of market share and reach. It relates to our raison d’être, i.e. to the positive impact of content and services on: – Societies – by offering a platform for information and democratic debate, reflecting the diversity of national and cultural identities, supporting social cohesion, providing a guarantee for plurality, producing and promoting European and local cultural productions, and preserving cultural heritage – Individuals – by supporting citizenship (information, representation, participation) – Cultural organizations, other public institutions, the media eco-system, the economy, and employment. When we connect to the networked society we create more opportunities to deliver public value – to empower citizens, to enable communities to deal with social issues, to bridge the digital divide, and liaise with other parts of society that create public value. Developing the concept of RoS offers a strong instrument for measuring success and defining priorities in our programmes and services. It allows us to focus more on fundamental issues, relating to the lives of citizens and the future of humankind. It can also strengthen the legitimacy of our activities. In an increasingly competitive environment, we have to be more distinctive, deliver greater value for money, and perform more effectively”.
[19] “E’ inutile chiedere che il Governo si faccia semplicemente da parte […]. Gli architetti delle scelte, pubblici o privati che siano, devono per forza fare qualcosa” (Thaler e Sunstein, p. 230). Peraltro è paradossale che se da una parte chiediamo al Governo di intervenire con forza in un settore (per es. imponendo la riduzione delle antenne in una città con la cosiddetta antenna unica sul tetto) dall’altro non consideriamo naturale che la tv pubblica possa divulgare informazioni sulle convenienze – estetiche e tecnologiche – dell’antenna unica per convincere i diversi condomini ad adottarla.
[20] Grasso, 2015.
[21] Jerome Bourdon (2015) Il servizio pubblico. Storia culturale delle televisioni in Europa, Vita e Pensiero in Grasso, 2015.
[22] Laddove inizialmente la chiave è stata quella della “coesione italiana”. Vedi De Blasio e Sorice, 2014, per un quadro generale del servizio pubblico in Europa e un’analisi comparativa delle diverse “missioni”.
[23] Giacomelli (2015)
[24] L’Ebu (2014) parla di « connecting with a networked society », partendo dal concetto di società reticolare e di un servizio pubblico che per adattarsi ai mutamenti sociali si trasforma in una organizzazione reticolare e individua strumenti reticolari di comunicazione.
[25] La legge appena votata al Senato prevede l’avvio di una consultazione pubblica.
[26] https://it.wikipedia.org/wiki/Verifica_qualitativa_programmi_trasmessi
[27] Barca 2007. Ma non va scordato che le televisioni locali hanno l’obbligo di trasmettere un notiziario che svolge, spesso ben più del TG regionale della Rai, una funzione pubblica e, per lo svolgimento di questo compito, ricevono denaro pubblico.
[28] Tenendo in mente che il divide digitale, cioè un divario di competenze nell’uso delle tecnologie, è una forma di segmentazione della popolazione che inasprisce il divario nella distribuzione del capitale sociale e culturale. Ed è un divario che aumenta in proporzione con l’aumento dell’utilizzo mondiale della rete: cioè maggiore è il numero di persone che produce, distribuisce ed accede a contenuti via internet, maggiore il gap interpretativo di coloro che ne sono esclusi.
[29] Brevini, 2015
[30] Burri 2015.
[31] Studiata da Erik Lambert per Infocivica e sintetizzata in Infocivica, 2014.
[32] Mazzucato, 2014, p. 15.
[33] Sarebbe un bellissimo obiettivo, per la Rai, quello di coinvolgere (con una spinta gentile) il Paese nella cura dei beni comuni. Per la produzione di una nuova identità nazionale collettiva. Per esempio iniziando il 2017 con una call a tutti i produttori per produrre idee in questo senso…
[34] Keynes J.M. (1926) « La fine del laissez-faire », in Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Utet, p.129 ; cit. in Mazzucato, 2014, p. 8.
[35] Quindi in progetti costosi e ad alto rischio di fallimento.